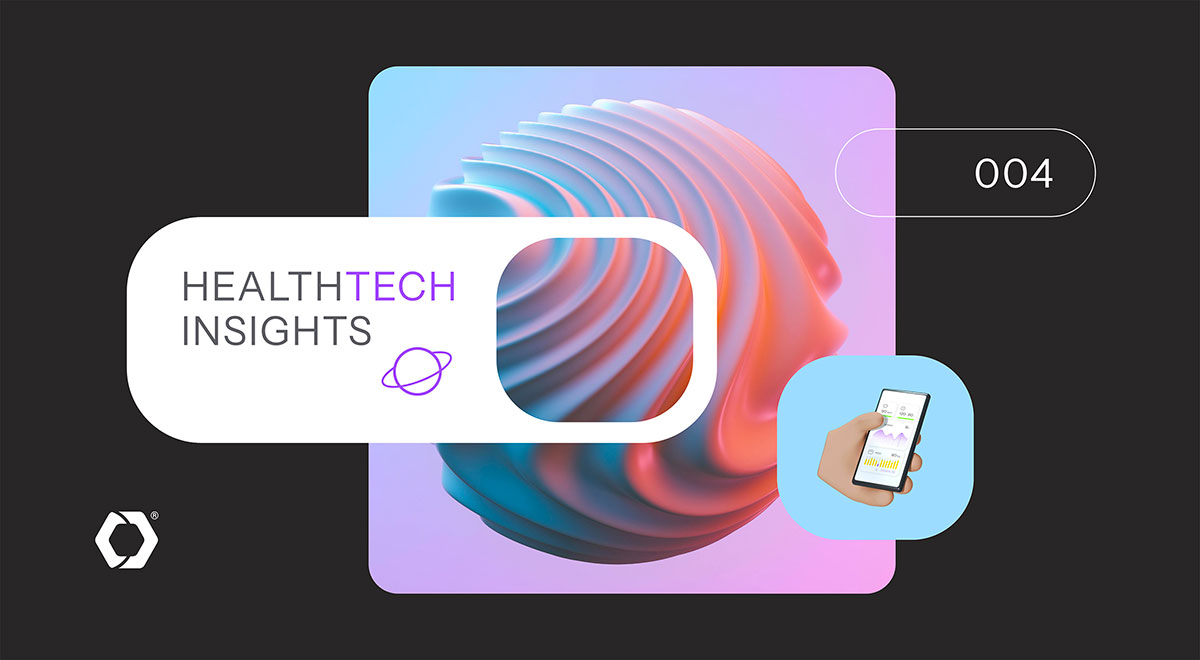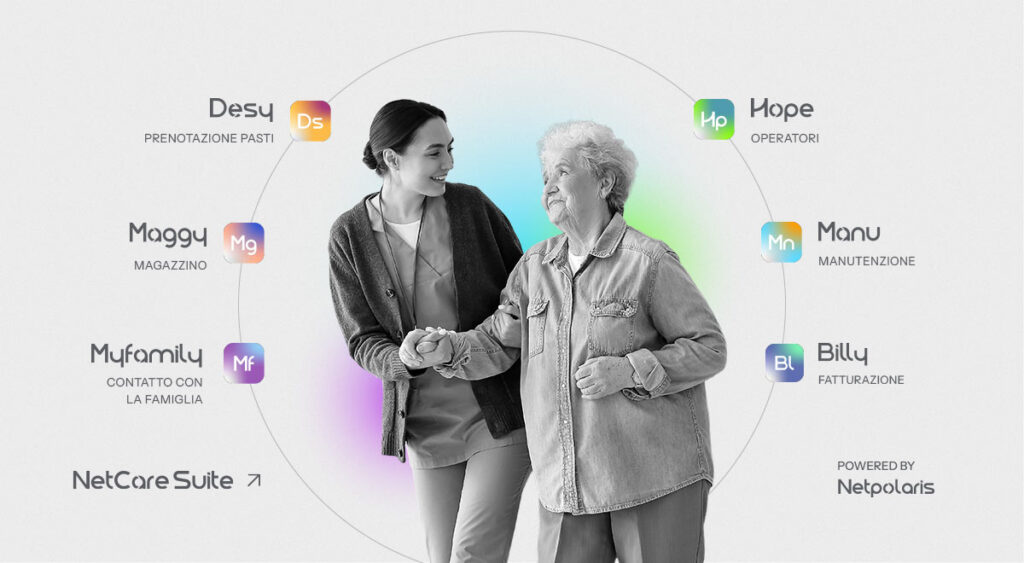“Una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località”: definisce così la telemedicina il Ministero, nelle linee guida approvate nel 2020 con le regole per visite, consulti, referti e teleassistenza che hanno visto dunque entrare la telemedicina nel Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2022, poi, il Governo ha chiarito i servizi minimi che l’infrastruttura regionale di telemedicina deve erogare: televisita, teleconsulto/teleconsulenza, telemonitoraggio, teleassistenza. Rispetto ad essi il paziente deve essere eleggibile secondo quattro parametri: la clinica, la tecnologia che ha a disposizione, la cultura, il livello di autonomia o la disponibilità di un supporto (caregiver o simili). È sempre il Ministero a specificare gli aspetti tecnici: la telemedicina prevede “la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. I servizi di telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico / terapeutico. Tuttavia, la prestazione in telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza. La telemedicina deve altresì ottemperare a tutti i diritti e obblighi propri di qualsiasi atto sanitario”.
Centrale resta, dunque, il rapporto personale che si instaura tra professionista e paziente, relazione da cui non si può prescindere. La facilitazione di vari aspetti che, però, la telemedicina può garantire è indubbia: essa permette ai pazienti di consultare i medici a distanza, senza doversi spostare fisicamente in ospedale o studio medico; le persone che vivono in zone remote o hanno difficoltà a muoversi possono beneficiare di una consulenza medica direttamente da casa; i pazienti possono essere monitorati a distanza, soprattutto quelli con patologie croniche, e i dispositivi medici possono raccogliere dati vitali e inviarli direttamente ai medici, che possono intervenire tempestivamente in caso di anomalie; le visite in remoto riducono il numero di appuntamenti fisici, alleggerendo il carico sulle strutture sanitarie e consentendo un risparmio di tempo sia per i pazienti che per i medici.

Anche dal punto di vista del coinvolgimento delle famiglie l’impatto può essere positivo: i parenti possono rimanere aggiornati sulla salute del loro caro grazie alle informazioni condivise tra il medico e il paziente, soprattutto in situazioni in cui il quest’ultimo è lontano o ha difficoltà a comunicare; la possibilità di consultarsi con i medici a distanza e di avere informazioni più trasparenti attraverso la cartella elettronica riduce lo stress per chi si occupa, in famiglia, del paziente; i familiari possono essere inclusi nei piani di cura grazie alla possibilità di accedere alle informazioni sanitarie del paziente, migliorando così la loro partecipazione e comprensione del percorso terapeutico. Anche la cartella elettronica, dunque, interviene in un processo di semplificazione e agevolazione di molti passaggi, essendo uno strumento che consente di archiviare tutte le informazioni sanitarie del paziente in formato digitale e permette agli operatori sanitari un accesso immediato alla storia clinica del paziente, alle prescrizioni e alle informazioni aggiornate – indipendentemente dal luogo in cui si trovano – e una comunicazione più fluida tra professionisti e famiglie. Tutto ciò evitando ritardi o errori dovuti alla mancanza di informazioni, alla – non sempre funzionale – gestione dei documenti cartacei, alla difficoltà di lettura della scrittura manuale.
A livello di sistema generale, l’introduzione della telemedicina può contribuire a rispondere alle esigenze di una popolazione che, in Italia, registra un forte invecchiamento e un aumento delle malattie croniche: grazie all’impiego di tecnologie avanzate e di nuovi modelli organizzativi di assistenza domiciliare, inoltre, la telemedicina entra a far parte degli elementi utili alla ristrutturazione e razionalizzazione del sistema sanitario nel suo complesso.
Partendo dal presupposto che il concetto di telemedicina è molto ampio, ci si può soffermare su alcuni aspetti più tecnici, che riguardano gli strumenti utilizzati nella pratica: i dispositivi IoT -apparecchiature mediche connesse a Internet (misuratori di glicemia, bilance, ECG); i dispositivi indossabili (wearables) – sensori che rilevano parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione, attività fisica, sonno); le piattaforme software – che, come The.0, raccolgono, elaborano e visualizzano i dati, inviano alert e report ai medici; la connettività – intesa come trasmissione sicura dei dati tra dispositivi e piattaforma (Bluetooth, Wi-Fi, reti cellulari). L’Internet of Things (IoT) è essenziale in molteplici applicazioni innovative, come le città intelligenti, le case intelligenti, l’istruzione, la sanità, i trasporti e le operazioni di difesa; per l’assistenza sanitaria il vantaggio consiste nel fatto che consentono il monitoraggio remoto sicuro e in tempo reale dei pazienti per migliorare la qualità della vita delle persone. Gli studi e il lavoro che attengono a questo settore devono ovviamente essere affiancati dalle garanzie in merito alla sicurezza e alla privacy sanitaria.

Per quanto riguarda i dispositivi indossabili – tendenzialmente i più diffusi, per la loro accessibilità e per le caratteristiche legate al “semplice” controllo della personale situazione di benessere fisico – si può senza dubbio notare come, nell’ultimo decennio, ci sia stata un esponenziale aumento della loro produzione e del loro utilizzo, a partire da Apple Watch, Fitbit e tecnologie simili, tramite i quali le informazioni sulla salute sono a portata di sguardo.
L’utilizzo consapevole di tali dispositivi concretizza il concetto di assistenza sanitaria proattiva, in cui i pazienti possono monitorare personalmente i segni vitali: nel caso in cui verifichino delle disfunzioni o delle variazioni poco comprensibili, gli eventuali problemi di salute potrebbero essere prevenuti, se non evitati. Tanti sono gli strumenti utili in questo senso, sia più comuni e diffusi, che più sofisticati e in fase di studio, elaborazione e implementazione. L’articolo, pubblicato su Forbes nel giugno del 2024, “ 14 Emerging Wearable Health Technologies Transforming Remote Caremembri” del Forbes Technology Council ne elenca una serie, che spesso prevedono l’uso dell’AI:
- la raccolta continua dei segni vitali tramite dispositivi indossabili;
- i cerotti microfluidici, che forniscono un’analisi in tempo reale dei biomarcatori corporei tramite un piccolo cerotto adesivo;
- gli ECG indossabili, il monitoraggio continuo del glucosio (CGM), che offre informazioni in tempo reale sui livelli di zucchero nel sangue, fondamentali per la gestione del diabete;
- l’elaborazione continua del segnale AI e il monitoraggio dei pazienti tramite essa;
- l’integrazione con EHR (Electronic Health Records) – la cartella elettronica;
- le protesi robotiche alimentate dall’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale;
- i biosensori indossabili – rilevano sottili cambiamenti nei biomarcatori;
- i tessuti intelligenti integrati nei sensori – essi monitorano continuamente i segni vitali e i movimenti, offrendo un monitoraggio non intrusivo della salute;
- gli smartwatch in grado di eseguire elettrocardiogrammi e rilevare ritmi cardiaci irregolari; la tecnologia epidermica, che prevede l’uso di cerotti sottili per letture continue della salute;
- la tecnologia iper-personalizzata, per cui i sistemi analizzano i dati dei dispositivi indossabili per offrire raccomandazioni e feedback personalizzati in base agli obiettivi e alle preferenze di salute individuali.
La telemedicina, che ad oggi è in fase di evoluzione e che certamente dovrà fare i conti anche con un cambiamento culturale, può – se ben strutturata e utilizzata – favorire il paziente e offrire un servizio migliore, per la più rapida disponibilità di informazioni sullo stato della sua salute, la – ci si augura – maggiore qualità e tempestività delle decisioni dei professionisti sanitari e, in prospettiva, un miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle cure, sempre preservando la riservatezza e protezione dei dati personali dei pazienti.